Hitler era socialista? Dipende da come definisci il socialismo.
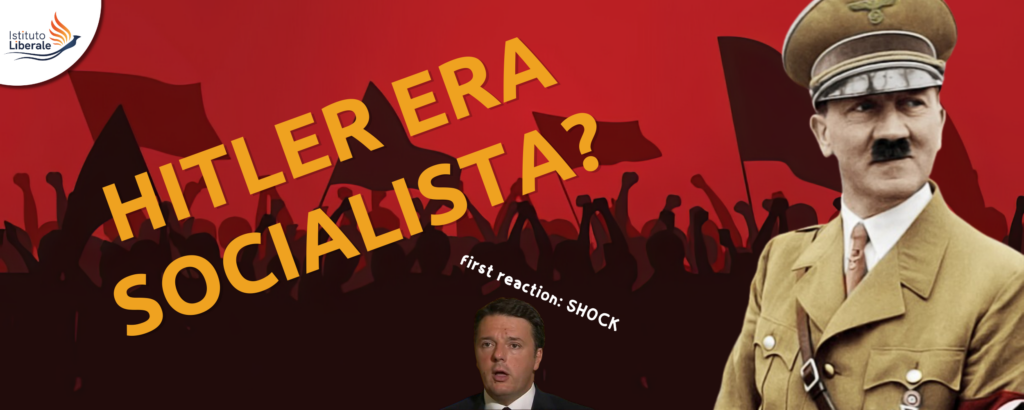
I nazisti non chiamarono la loro ideologia “nazionalsocialismo” solo perché suonava bene. Erano profondamente ostili al capitalismo. Il principale propagandista del partito, Joseph Goebbels, arrivò persino a dire che avrebbe preferito vivere sotto il bolscevismo piuttosto che sotto il capitalismo. Il regime nazista avviò imponenti progetti di lavori pubblici, come la costruzione dell’autostrada, promise la […]
Ecologia, conservazione e sviluppo in assenza di Stato (4); M.N. Rothbard (For a New Liberty, analisi 2^ parte)
Conservazione, ecologia e sviluppo: In questa sezione, Rothbard affronta un cavallo di battaglia dei liberal di sinistra e dei socialisti, ovvero l’ecologia, la tecnologia e il loro rapporto col libero mercato e il capitalismo. A detta di Rothbard, i liberal di sinistra vedono nello Stato la soluzione per ogni problema, tra cui ovviamente il rispetto […]
Breve apologia dell’individualismo
Sentir usare la parola individualismo in senso positivo fa storcere il naso a molti. Essa è una parola che ha assunto un valore negativo per la maggior parte delle persone, basti pensare alla dicotomia individuo-società, dove il polo positivo è rappresentato, nel senso comune, dal secondo termine. Per i più questa è una opposizione binaria […]
Riflessione Liberale sul Comunismo
Il comunismo è la volontà di controllare tutto, è la paura della libertà. In psicologia la mania del controllo è riconosciuta come un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità, in politica viene chiamata socialismo. Vediamo insieme questo brano: “I rapporti borghesi di scambio e di produzione, i rapporti borghesi di proprietà, la società borghese moderna, che ha […]
