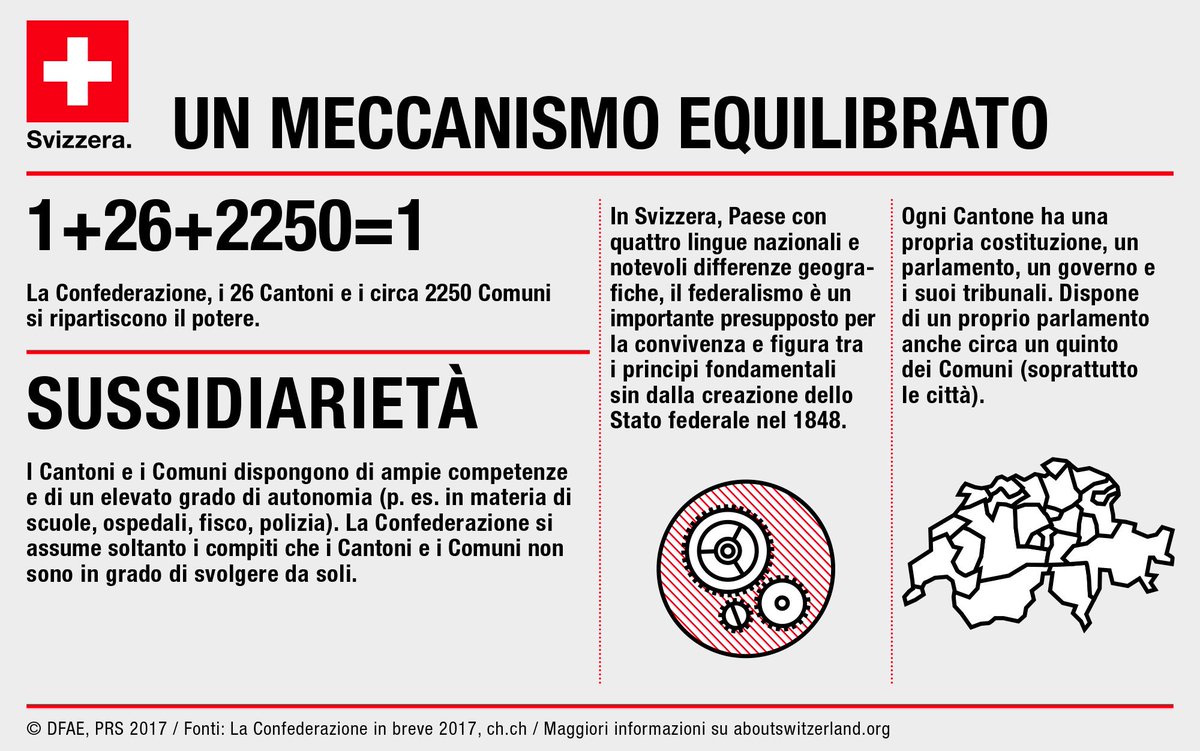Ho appena finito di vedere l’ennesimo video su YouTube in merito ad un tema che mi sta molto a cuore, ovvero il Gender Pay Gap.
Questo video, creato da un ragazzo molto competente in economia come Giorgio De Marco di What’s Up Economy non mi ha lasciato particolarmente soddisfatto, per questo motivo vorrei permettermi di dire la mia sul tema del Gender pay gap.
Messo e concesso che al mondo esistono diverse forme di discriminazione e che non è solo un nostro diritto, ma un nostro dovere quello di combatterle, ritengo che queste teorie, nel modo in cui vengono sviluppate ed argomentate, spesso e volentieri rasentino il complottismo.
Inoltre, ci tengo a sottolineare come i dati portati a galla possano essere quantomeno pericolosi se dovessero capitare nelle mani sbagliate, ovvero di coloro che vogliono vedere una sorta di disegno della società, con l’intento di discriminare qualche minoranza.
Pensiamo ai collettivisti di stampo post-marxista, ai quali magari potrebbero fare gola dati di questo genere, utili per invocare uno (sbagliato) intervento dello stato ed una distorsione del mercato del lavoro (Che, come ci insegnano gli austriaci, porta sempre effetti controproducenti), oppure per guadagnarci in visibilità, portando avanti quella che Dave Rubin definirebbe come un’ “olimpiade dell’oppressione”.
Ma partiamo dall’inizio.
Come ho detto precedentemente, sono molto contrario a delle rilevazioni di questo tipo per motivi ideologici, ma le sostengo quando vengono fatte esclusivamente con l’intento di analizzare un fenomeno sociale.
Le sostengo, soprattutto quando i soggetti che vengono considerati come oppressori nei confronti di altre categorie sociali sono i soliti bianchi maschi etero. E questo, sia perché -tra le tante- rientro anche in queste categorie, sia perché sono un grande sostenitore della teoria di Jordan Peterson secondo cui “Per essere in grado di pensare, devi correre il rischio di essere offensivo”.
Ma, soprattutto, perché non sopporto chi, perseverando nell’errore che spesso viene fatto da molte minoranze nel mondo, sventola dati fasulli o manipolati nel tentativo di dimostrare una discriminazione sistematica al giorno d’oggi nel loro paese, di qualsiasi tipo essa sia.
Prendiamo ad esempio, sempre in America, il mito del razzismo dei poliziotti statunitensi, portato avanti da alcuni movimenti di Giovani studenti della sinistra in America, che vorrebbero far passare il messaggio secondo cui nel loro paese vi sia una sorta di razzismo sistematico da parte dei poliziotti nei confronti delle persone di colore.
Questi dati, se così vogliamo chiamarli, si basano spesso su una mala interpretazione delle rilevazioni statistiche e sono spesso stati smentiti da persone come Larry Elder, in una delle ultime interviste da “liberal” condotte negli USA da Dave Rubin .
Quello che voglio dire, è che non sostengo minimamente quelle ricerche portate avanti con l’unico scopo di stuprare la matematica nel solo tentativo di portare alla luce risultati distorti, deludenti, o peggio ancora totalmente fuorvianti, che prendendo la parte per il tutto o invertendo causa ed effetto, vogliono dimostrare che se una discriminazione esiste, allora essa è necessariamente sistematica.
Inoltre, essendo uno studente di Matematica vicino alla fine del mio percorso di studi, ed essendo in particolare un amante della Probabilità e della Statistica, conosco molto bene quali possono essere i limiti nelle rilevazioni dei dati per portare avanti un’indagine.
Volendo in questo articolo riferirmi in particolare alla supposta discriminazione del mercato nei confronti delle donne (che si riflette nel così detto Gender pay gap), mi permetto di cominciare facendo un esempio di come la matematica e la statistica possano rivelarci dati sbagliati in base a come vengono presi in considerazione. Supponiamo che in Italia ci siano 100 lavoratori in Lombardia e 100 in Puglia. Immaginiamo che i 100 lavoratori in Lombardia siano 60 uomini e 40 donne e che i lavoratori in Puglia siano 40 Uomini e 60 donne. Supponiamo che tutti i 100 lavoratori lombardi guadagnino la stessa cifra, ad esempio 5000$ e che anche i lavoratori Pugliesi guadagnino tutti la stessa cifra, supponiamo 1000$.
Se prendessimo in considerazione i due gruppi, quello Lombardo e quello Pugliese, vedremmo che non c’è nessuna discriminazione di genere e che il salario di quei lavoratori è condizionato più da fattori regionali che da altri. Eppure, prendendo la media del salario di tutte le donne Lombarde e Pugliesi (40×5000+60×1000 e dividendolo per 100, ottenendo 2600$) e di tutti gli uomini Lombardi e Pugliesi (60×5000+40×1000, dividendo per 100, ottenendo 3400$) e facendo il loro rapporto, si ottiene che ogni donna guadagna 0.76$ per ogni 1$ di un uomo. Ma come abbiamo visto prima, non c’è alcun tipo di gender pay gap all’inizio, se non una differenza dovuta a diverse condizioni tra lavoratori in due regioni diverse.
Questo solo per fare un esempio, ma andiamo più nel dettaglio.
Consideriamo il caso americano e facciamo un passo indietro: il mito del Gender pay gap è esploso negli USA negli anni della presidenza Obama, durante la quale anche l’allora presidente degli Stati Uniti portava avanti istanze come “le donne negli Stati Uniti guadagnano 0.77 cent per ogni dollaro che un uomo guadagna!”. Questa affermazione, prendeva in considerazione il salario medio guadagnato da TUTTE le donne negli USA, ponendolo al numeratore della frazione e portando al denominatore la media dei salari di TUTTI i lavoratori di sesso maschile.
Nel fare ciò, immagino che anche voi possiate capire come questa rilevazione non significhi nulla, perché non tiene conto infinite altre variabili. Ed è qui che vorrei attirare la vostra attenzione e dove ci terrei a farvi capire quali possono essere le limitazioni in base ai dati presi in considerazione.
La parola chiave è variabili.
Se siete degli individualisti come me, immagino che sappiate già che ogni individuo, pur appartenendo ad una determinata categoria sociale può essere diametralmente opposto ad un suo “simile”, quindi spesso risulta già fuorviante confrontare persone appartenenti alle stesse categorie.
Ma in statistica è difficile, se non impossibile, effettuare una rilevazione individualista della realtà. Risulta quindi difficile non avvicinarsi alla metodologia mainstream, rifiutando la visione Austriaca dell’Economia.
In tal modo, quindi, gli statistici tendono a considerare nelle loro analisi una sorta di “collettivizzazione” delle persone, nel tentativo di rendere più facile una matematizzazione della realtà.
Ma nel fare ciò, però, si rischia di essere fuorvianti. Soprattutto in economia.
Vi faccio un altro esempio, prendendo in considerazione una scienza “pura” quale la climatologia. Essa, al pari della Fisica, dell’astronomia, della Biologia e della Chimica, si basa su una certa interpretazione di dati “oggettivi”, nudi e crudi.
Eppure, già qui le diverse interpretazioni proposte dai diversi scienziati raccontano realtà spesso opposte le une dalle altre.
Come sappiamo, la scienza si basa su due cose: sui dati (che vengono presi, ed in quanto tali, non discutibili in quanto valori assoluti) e sulle loro interpretazioni.
Ed è proprio in quest’ottica che ad esempio si arriva a creare una discussione ancora oggi presente sul surriscaldamento globale.
Alcuni potrebbero far vedere che l’aumento della CO2 comporta un aumento della temperatura. Altri, potrebbero obiettare il contrario. Altri ancora, potrebbero prendere in considerazione dei dati in un arco di tempo più lungo, facendo notare un andamento “armonico” della temperatura nel corso della storia e via discorrendo, creando teorie che – partendo solo da un particolare differente – portano a conclusioni opposte.
E questo in una scienza “pura”, dove non vengono presi in considerazione troppi dati “soggettivi” e dove l’interpretazione dei primi dati è molto limitata.
Pensate allora all’Economia ed ancor più in particolare alle analisi condotte sul mercato del lavoro, dove i dati da prendere in considerazione di stampo “oggettivo” già sono parecchi, ed alla quale se ne potrebbero aggiungere un’altra infinità di stampo soggettivo.
Tra i primi potremmo considerare il sesso delle persone, la nazione dove lavorano, la regione della stessa, la città in cui lavorano, la ditta per cui lavorano, il loro titolo di studi, la loro specializzazione, il tipo di contratto (se part-time o a tempo pieno ad esempio), le ore di lavoro, le ore di straordinario fatte, lo stipendio stesso, l’età, l’età lavorativa e la relativa esperienza e molte altre.
Prendiamo ad esempio due individui che dovendo andare a lavorare a Bologna, uno da Imola ed uno da Milano, richiedano al loro datore di lavoro dei rimborsi per gli spostamenti. È probabile che quello che partirà da Imola prenderà necessariamente qualcosa in meno rispetto al secondo. E di questi dati, spesso molto nascosti da una parte o dall’altra ce ne sono sempre in agguato.
E tra di essi, magari, perché non prendere in considerazione magari dei dati più “soggettivi”, di stampo sociologico e comportamentale, che possono avere a che fare con il carisma, con il carattere, con l’attitudine della persona sul luogo di lavoro? Questi non sono dati facilmente reperibili perché non quantificabili, ma che sicuramente influiscono sullo stipendio finale dell’individuo.
Ad esempio, in questo ambito possono tornarci utili le parole di Jordan Peterson, il quale, basandosi su delle ricerche fatte da dei suoi colleghi ha rilevato ad esempio che in media i ragazzi e le ragazze hanno differenze comportamentali rilevanti.
I primi, risultano essere infatti più materialisti, più inclini alla violenza e al pericolo, mentre le donne sviluppano caratteri più legati all’emotività ed un attaccamento maggiore nei confronti dei legami interpersonali. Ciò chiaramente non ci dà una spiegazione dettagliata, ma può risultare essere un buon punto di inizio per comprendere quanto possa essere difficile la scelta dei parametri da prendere in considerazione.
Ma non sono certo qui a voler dire che bisogna buttare nella spazzatura qualsiasi ricerca fatta nel tentativo di ricercare la verità.
Quindi, prendiamo in considerazione alcuni dati che ci possono tornare utili per capire meglio questo Gender Pay Gap (sempre in America).
Una ricerca del 2017 condotta da Valentin Bolotnyy e Natalia Emanuel , entrambi economisti di Harvard, hanno rilevato dagli operatori sindacali di autobus e treni che questo gap si annulla totalmente se prendiamo in considerazione le scelte fatte dagli stessi lavoratori.
L’indagine ha preso in considerazione lavori sindacalizzati, in quanto venivano lasciate ai manager poche capacità decisionali in merito ai salari dei lavoratori, che potevano essere accusati di imparzialità, e ha lasciato ai ricercatori la possibilità di soffermarsi esclusivamente sul comportamento dei lavoratori.
La rilevazione statistica, a parità di lavoro e di mansione ha rivelato che:
“Le donne usano il Family Medical Leave Act (FMLA) per prendere più tempo libero non retribuito rispetto agli uomini e lavorare meno ore di straordinario con salari 1,5 volte superiori. La radice di queste diverse opzioni è il fatto che le donne apprezzano il tempo e la flessibilità più degli uomini.”
Oppure, che:
“Il divario di reddito può essere spiegato nel nostro ambiente dal fatto che gli uomini prendono il 48% in meno di ore non retribuite e fanno l’83% in più di lavoro straordinario all’anno rispetto alle donne. La ragione di queste differenze non è che uomini e donne affrontano diversi set di opzioni in questo documento. […] Queste differenze di genere sono coerenti con le donne che assumono più mansioni domestiche e di assistenza all’infanzia rispetto agli uomini, limitando la loro disponibilità di lavoro nel processo. […] Quando gli straordinari sono previsti con tre mesi di anticipo, gli uomini si iscrivono per circa il 7% in più rispetto alle donne.”
Allo stesso modo, possiamo prendere in considerazione uno studio di Claudia Goldin, ricercatrice di Harvard, la quale, nelle sue ricerche ha rivelato che questo gender pay gap muta in base al settore che viene preso in considerazione.
Lo studio, ha infatti riportato che nei settori Scientifici e tecnologici, dove probabilmente la qualità di un lavoratore è valutata in maniera più “oggettiva”, dove le specializzazioni e le mansioni sono poche questo gap si accosta quasi allo 0, in alcuni casi si inverte addirittura l’andamento.
A dirla tutta, la stessa Goldin durante la discussione di questa sua tesi all’AEA (American Economic Association) arriva esattamente alla mia conclusione, ovvero che un certo gap esiste, così come esiste senza ombra di dubbio la discriminazione. Ma è fuorviante pensare che questo tipo di discriminazione sia di tipo sistematico e che il mercato sia automaticamente discriminatorio nei confronti delle donne.
In ogni caso, continuando sempre secondo l’analisi della Goldin abbiamo anche una conferma di quanto detto prima. Infatti, sempre all’interno della sua rilevazione statistica si ha che il settore del Business evidenzia un andamento del Gender wage gap ancora maggiore rispetto a quello dei precedenti settori evidenziati. Perché?
Beh, si può tenere in considerazione il fatto che all’interno di questo settore le professioni variano, così come i compensi. Ci saranno donne che saranno CEO, imprenditrici, o che guideranno interi istituti di ricerca, così come ne esisteranno altre che copriranno mansioni meno retribuite, come ad esempio segretarie e quant’altro (dove il tasso di donne è molto superiore a quello di uomini).
Inoltre, in questi settori dove con ogni probabilità entrano in considerazione fattori che hanno a che fare con dei parametri molto soggettivi, si ha un aumento di questo differenziale (esattamente come affermato prima).
Si tratta, infatti, di lavori dotati di poca flessibilità e che automaticamente portano ad avere degli svantaggi sulla carriera lavorativa di chi ne richiede di più (In particolare, secondo l’indagine della Goldin, le donne).
Non solo, possiamo prendere in considerazione un articolo uscito sempre nel 2017 sul The Economist, che evidenzia come questo gap arriva a diminuire costantemente (in paesi come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania) considerando solo fattori come il lavoro, il medesimo lavoro a medesimo livello di responsabilità, nella medesima compagnia e a parità di mansioni.
E in tutto ciò, come non prendere in considerazione anche le citazioni della nostra Christina Sommers, la quale, nel suo video promosso da PragerU ha evidenziato che la AAUW (American Association of Univeristy Women) ha rilevato che prendendo in considerazione alcune differenti scelte fatte da uomini e donne all’interno dello stesso settore, il gender pay gap arriva ad assottigliarsi dai famosi 0.23$ precedentemente citati negli USA a 0.066$ per ogni dollaro che un uomo guadagna. Tesi confermata anche da altri studi condotti .
In tutto ciò, possiamo citare che un’altra ricerca molto interessante fatta da tre economisti in merito al Gender Pay gap, i quali hanno rilevato che le donne nate dal 1948 in poi, una volta superata la soglia dei 40 anni, hanno visto il loro gap salariale ridursi costantemente, fino ad avvicinarsi allo zero. Perché questo? Semplice.
Nella fascia d’età che va dai 20 ai 40 anni, le donne è probabile possano avere una gravidanza, la quale è senza ombra di dubbio una penalizzazione dal punto di vista lavorativo e della carriera.
Secondo un video promosso sempre dal The Economist , le donne che tornano a lavoro dopo un periodo di maternità si vedono tagliato il loro salario in media del 4%.
Ora stiamo tutti calmi e ragioniamo. La gravidanza, come precedentemente detto, ti penalizza? Dal punto di vista lavorativo, la risposta è senza dubbio: SI.
Ma guai a cadere nella tentazione di dire “le donne sono oppresse”, in quanto una gravidanza comporta per entrambi i coniugi molti sacrifici. Una madre potrebbe guadagnare di meno e per compensare questa perdita, il padre potrebbe essere più incentivato a richiedere più ore di straordinario (il che potrebbe essere anche una motivazione per cui gli uomini richiedono più spesso delle donne degli straordinari). Siamo sinceri, quante coppie soprattutto in caso in gravidanze complicate, preferirebbero far rimanere a casa le proprie mogli per evitare loro sforzi inutili che possano mettere a repentaglio la loro salute e quella del bambino, sacrificandosi a lavoro, cercando di guadagnare qualcosa in più?
Come dice sempre Jordan Peterson, la vita è ingiusta ed è piena di sofferenze ed è solo la collaborazione tra uomini e donne che può renderci più liberi. Ed è da questa concezione, che nasce anche il patriarcato (di cui magari parleremo un’altra volta, dato il tema parecchio controverso).
Inoltre, questa dinamica può spiegare perché sempre in America ci sia una divisione delle mansioni domestiche divisa iniquamente a sfavore delle donne.
Non si tratta di imposizione, ma di necessità e di scelta il più delle volte, così come è una scelta decidere di diventare genitori e sia essere padre che essere madri comporterà una certa dose di responsabilità.
Ma mettiamo un attimo da parte la questione coniugale e prendiamo ad esempio in considerazione la differenza salariale tra uomini e donne non sposati.
Qui ci torna utile Andrew Syrios, il quale in un articolo pubblicato per il Mises Insitute ci fa sapere che:
“Quando le donne mai sposate vengono paragonate a uomini mai sposati, il divario salariale non solo scompare, ma cambia. Già nel 1971, le donne che non erano mai state sposate sulla trentina hanno guadagnato un po’ più degli uomini. Nel 1982, le donne che non si sono mai sposate insieme hanno guadagnato il 91 percento di quello che hanno guadagnato gli uomini. Oggi, tra uomini e donne che vivono tra i ventuno e i trentacinque anni, non vi è alcun divario salariale. E tra uomini e donne single con un’istruzione universitaria di età compresa tra i quaranta e sessantaquattro anni, gli uomini guadagnano in media $ 40.000 all’anno e le donne guadagnano in media $ 47.000 all’anno”
E non è l’unico a dircelo, possiamo prendere in considerazione anche altri studi effettuati da professionisti che rivelano che questo gap è senza ombra di dubbio dovuto nella stragrande maggioranza dei casi alle diverse scelte fatte da uomini e donne durante la loro vita lavorativa.
Possiamo infatti prendere in considerazione uno studio della CONSAD Research Corp. per il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti che scoprì che una volta controllate le variabili, c’era “un divario salariale adeguato al genere che oscilla tra il 4,8% e il 7,1%”.
Oppure, uno studio di June e Dave O’Neill per il National Bureau of Economic Research ha rivelato che “il divario di genere è in gran parte dovuto alle scelte fatte da uomini e donne in merito alla quantità di tempo ed energia spesa a una carriera“.
Di studi se ne possono prendere tanti altri, e tutti arriverebbero tranquillamente a confutare che questo divario possa essere determinato da una sorta di discriminazione sistematica da parte del lavoro nei confronti delle donne.
Detto ciò, però, vorrei arrivare a questo punto ad una mia conclusione: Indipendentemente se siamo uomini o donne, abbiamo il dovere di combattere ogni forma di discriminazione all’interno della nostra società. Ma rigettiamo l’idea di essere sistematicamente oppressi, in quanto soprattutto nella nostra società occidentale, nessun diritto è negato.
Se un uomo vuole essere segretario, che lo sia. Se una donna vuole puntare ad essere CEO, che ce la metta tutta per raggiungere i suoi traguardi.
Ma rigettiamo tutti insieme l’idea che di una sistematicità di questa discriminazione da parte del mercato, in quanto anche se esistesse, sarà il mercato stesso a fare la sua selezione naturale.
Superiamo gli stereotipi e prendiamoci la responsabilità delle nostre decisioni e delle nostre azioni, ma soprattutto, non invochiamo un aiuto statale per interventi che possono solo fare del male alla nostra economia. Cerchiamo l’uguaglianza, affinché le nostre scelte non siano dettate da nessun altro se non da noi e lavoriamo tutti insieme cercando di capire che non ci sono categorie più o meno oppresse, ma che tutti noi anche in maniera collettivista portiamo i nostri macigni sulle nostre spalle e solo la collaborazione tra di noi può portarci a ritrovare la felicità di cui abbiamo veramente bisogno.
Andiamo avanti, e a chi ci dirà d’ora in avanti che il sistema ci opprime, ricordiamo che il sistema siamo noi e che se siamo arrivati a lamentarci delle scelte che ogni giorno facciamo per realizzarci, allora il problema non va cercato certamente all’interno della società, bensì dentro noi stessi.